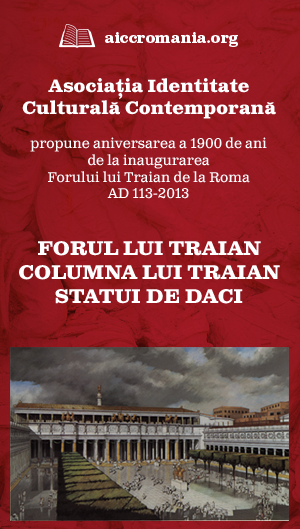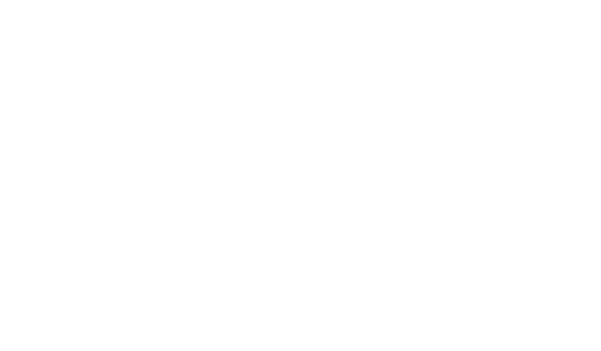il Rinascimento, il Barocco, ..., ecc.
Il più imponente monumento trionfale mai costruito, la Colonna di Traiano è una delle opere scolpite in pietra (marmo) la più completa che l’Antichità ci ha lasciato, una fonte feconda di studio per storici, archeologi e artisti di tutto il mondo. La Colonna Traiana è da sempre uno dei più famosi monumenti di Roma.
Dal Quattrocento (XV secolo italiano), la Colonna di Traiano ha destato l’attenzione degli artisti: prima di Bernini, la Colonna è stata studiata da Raffaello Sanzio e Giulio Romano e di tutti i grandi maestri ed era davvero la fonte dove tutti i grandi artisti hanno trovato il potere e la grandezza creativa delle loro opere1.
All’inizio del XVI secolo, tra i primi artisti del Rinascimento italiano che hanno studiato la Colonna è stato il pittore Jacopo da Bologna, che anche prima dell'anno 1506, mostrava un grande interesse per i suoi bassorilievi. Poi, questo monumento dell'Antichità destava sempre di più un interesse vivo e una notevole influenza sui più grandi artisti del Rinascimento, sugli affreschi di Raffaello Sanzio, le famose Stanze e sui lavori del suo allievo, Giulio Romano del Vaticano; si sa che Michelangelo stesso aveva ammirato le scene della Colonna Traiana, di fronte ai quali avrebbe esclamato: C'è solo una colonna di Traiano! . Più tardi, nel secolo successivo, lo stile in cui sono stati scolpiti i bassorilievi della Colonna Traiana dagli artisti antichi avranno influenza sulle forti composizioni del Caravaggio. Le grandi opere del Rinascimento essendo sempre più sotto “l’influenza” dell’arte della Colonna, questi rilievi hanno suscitato un crescente interesse e studi su larga scala sono stati avviati; anche dei calchi sono stati fatti da questi quadri di marmo di Carara. Nel 1541, il re di Francia, Francesco I, ha inviato il pittore Primaticcio a Roma, con la raccomandazione di realizzare riproduzioni secondo le più belle sculture in marmo, nonché secondo la Colonna Traiana. Questo lavoro di grandi dimensioni è stata avviata e condotta dall'architetto Vignola; questo si trovò ben presto costretto a riconoscere che questo progetto era troppo ampio e troppo costoso, inviando solo pochi frammenti per soddisfare la curiosità del re. Portate a Fontainebleau, questi gessi sono scomparsi senza lasciare traccia (nessuno sa se esistono ancora). Lo stesso con i calchi realizzati su ordine di Luigi XIV, hanno avuto la stessa sorte; l’intera colonna è stata modellata. Il primo direttore dell'Accademia di Francia, fondata sotto gli auspici di Colbert, Ch. Errard, supervisionava le operazioni, che durarono fino al 1640. Ma questi gessi non sono tutti arrivati in Francia. Alcuni sono disponibili presso la Villa Médicis, altri sono stati a lungo tenuti nel Deposito delle Antichità, poi in uno dei dipartimenti di antichità del Louvre; una terza parte si trova al Museo dell'Università di Leyde (Paesi Bassi). Parallelamente a questi lavori di riproduzione, un libro sulla Colonna Traiana, stampato a Roma, apparirà per la prima volta nel 1576 (ristampato nel 1585, 1616): 130 tavole incise da F. Villamena secondo i disegni (totalità del fregio) di Girolamo Muziano (1530-1590), direttore dei lavori del Vaticano accompagnate da un Commentarium , scritto dallo spagnolo studioso Alfonso Chacon (Ciaccone), Historia utriusque belli Dacici a Traiano Caesare gesti, ex simulacris quae in Columna eiusdem Romae visunteur collecta. Nel 1667 l’incisore Pietro Santi Bartoli (1635-1700), allievo di Nicolas Poussin, esegue altre incisioni in rame, secondo la Colonna Traiana, che sono state pubblicate, accompagnate da un commento di Chacon, corretto e completato da Pietro Bellori: Colonna Traiana eretta dal Senato e Popolo Romano all’ Imperatore Traiano Augusto nel suo Foro in Roma... Notiamo anche il lavoro di Raffaello Fabretti, De Columna Traiana Syntagma, Roma, 1683-1690, e le splendide incisioni di Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), Trofeo o sia magnifica colonna coclide di marmo composta di grossi macigni ove si veggono scolpite le due guerre daciche fatte da Traiano, Roma, 1776, da vedere anche: Vedute delle colonne Antoniana et Trajana, Roma, 19652.
Copie e riproduzioni dalla Colonna Traiana conservate ed esposte nei vari musei :
- Museo della Civiltà Romana (Sala LI: La Colonna Traiana), a Roma, presenta una delle tre serie di copie fatte nel 1861 da Napoleone III, che ha donato queste copie al Papa Pio IX (in totale sono 125 riproduzioni fatte in gesso). Le metope sono esposte attualmente su quattro file (che si svolgono su circa 200 metri.), e permettono un’osservazione perfetta e da vicino (al livello degli occhi) di tutti i rilievi della Colonna di Traiano ;
- Il Museo d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye (Francia) ha una riproduzione fatta secondo il metodo della galvanoplastica nel sec. 19 (1865), solo per la parte inferiore delle scene della Colonna, e che sono esposte su un tamburo di legno nel fosso di difesa del castello (Saint-Germain-en-Laye) ;
- Il Museo del Louvre conserva nella sua collezione di calchi, che si trovano a Versailles (Petites Écuries de Versailles), circa un terzo dela totalità del fregio della colonna, nonché tutta la base ;
- Uno stampo completo è presentato al Victoria and Albert Museum, Londra ;
- Museo Nazionale di Storia di Bucarest, presenta un calco completo secondo la Colonna, fatto durante la Seconda Guerra Mondiale3.
Le rappresentanze della Colonna Traiana (immagine generale, studio della colonna dal punto di vista architettonico, gli studi secondo le sue scene storiche, ecc) nelle opere delle correnti artistiche, Rinascimento, Barocco, Rococò, Neoclassicismo, Realismo, Naturalismo, ecc., ai grandi artisti di fama mondiale, sono molto numerosi.
Pietro Santi Bartoli
Pietro Santi (Santo, Sante) BARTOLI (1635-1700) è un incisore, disegnatore e pittore italiano, è nato quasi nell’anno 1635 a Perugia (Ombria) ed è morto a Roma il 7 novembre 1700. Bartoli lascierà ben presto la città natale et abiterà a Roma, dove comincierà da giovane la sua futura carriere artistica, per primo lui studia la pittura, essendo l’allievo di P. Lemaire e di Nicolas Poussin, di cui lui a apperso a disegnare con eleganza dei monumenti antici. Poi lui studierà i segreti dell’arte dell’incisione dedicandosi esclusivamente. Sempre durante questo periodo lui lavorerà come “antiquario” nel servizio della papa e della regina Cristina di Svezia.
Attraverso dell’incisione Bartoli si è proposto di riproducere una serie di monumenti antici grechi e romani di Roma per farli conosciuti di più al pubblico. Lui ha fatto durante la sua vita artistica circa 12 lavori (albumi), illustrando circa 900 di tavole, essendo considerevole tra l’accuratezza e la purità di loro disegno. Una maggioranza di questi incisioni ha risalito a Roma e sono stati in genere accompagnate da un testo scritto dall’eurdito Giovan-Pietro Bellori (1613-1696 – scrittore, archeologo, conservatore degli oggetti antichi di Roma, storico, critico di arte, biografo italiano).
Le principali pubblicazioni di Pietro Santi Bartoli sono :
- Admiranda Romanarum antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia, Roma, 1693, in-folio, 84 pl. ;
- Romanae magnitudinis monumenta (138 pl.) ;
- Veteres arcus Augustorum triumphi insignes, Roma, 1690, in-folio, 40 pl.;
- Gli antichi sepolcri, avvero mausolei romani ed etruschi trovati in Roma (Tombeaux antiques ou mausolées romains et étrusques trouvés à Rome), 1697, in-folio, 110 pl. ;
- Le Pitture antiche delle grotte di Roma e del sepolcro de’Nasoni (Peintures antiques des grottes de Rome et du tombeau des Nasons), 1706, in-folio, 75 pl. ;
- Le antiche lucerne sepolcrati…(Lampes sépulcrale antiques…), in-folio, 110 pl. ;
- Colonna Traiana eretta dal Senato, e Popolo Romano all'Imperatore Traiano Augusto nel suo foro in Roma, Roma, Gio. Giacomo de Rossi, 1673, in-folio oblong, 127 pl. (tranne la dedicazione incisa dopo Charles Errard) ;
- Colonna Antonina, Gli antichi sepolcri, 1697, in-folio (75 pl.) ;
- Nummophilacium Reginae Christinae…(Médailler de la reine Christine…), 1742, 63 pl. ;
- Museum Odescalchum, sive Thesaurus antiquarum gemmarum…(Musée Odescalchi ou Recueil de pierres gravées antiques faisant partie de la collection de la reine Christine), 1747 şi 1751, in-folio, 102 pl. ;
- Fra 1758-1783 è stato pubblicato a Parigi un Recueil de peintures antiques dopo i disegni colorati di Bartoli, con una descrizione di P. Mariette şi Comte de Caylus. Questi disegni, con un numero di 33 sono tenuti in "Cabinet des estampes», à Parigi. Bartoli, inoltre, ha fatto una serie di incisioni secondo i pittori moderni : Raphaël (la Vatican), Lanfranc, Ann. Carrache, Jules Romain, Albane, Fr. Mola,, Cortone, Pietro Testa, etc.
Osserviamo nelle incisioni di Bartoli, realizzate secondo i bassorilievi della colonna Traiana, la meravigliosa precisione della linea e l’esattezza dei dettagli.
Giovanni Paolo Panini
Giovanni Paolo PANINI (o PANNINI) (1691-1765) fu un pittore barocco italiano, nella prima fase della sua carriera artistica Giovanni Paolo Panini studia e si forma negli ateliers dei grandi specialisti in prospettiva, lavorando con grandi artisti della grande famiglia Bibiena (Galli da Bibbiena, artisti italiani originari della città di Bibbiena, nella provincia d’Arezzo), e cominiciò dedicarsi alla decorazione dei palazzi nello stile « trompe-l’œil ». Invece lui divienne particolarmente conosciuto per sue quadri « vedute » e « capricci », visti che contengono in modo immaginario dei monumenti e delle rovine reale dell’antica Roma.
Il suo stile avrà un influenza sul lavoro dell’artista veneziano Canaletto (1697-1768) e i seguenti artisti, adepti di questo « corrente artistica », e più tardi Hubert Robert (1733-1808) chi diviene il suo allievo.
Nelle sue opere, Giovanni Paolo Panini realizza una serie di « vedute ideale », riunendo in modo immaginario tanti monumenti reali antici romani, la colonna di Traian, di Marcus Aurelius, Arco di Constantin, « Colosseum » (« Amphitheatrum Flavium »), Pantheon, statua equestre di Marcus Aurelius, ecc. Lo stile di sua esecuzione è preciso e dettagliato, l’alta qualità del dettaglio e dell’elemento artistico deve essere apprezzato e ammirato.
Giovanni Battista PIRANESI
Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778), nato il 10 aprile 1720 a Mogliano Veneto, vicino Treviso, morto a Roma il 9 novembre 1778, è un incisore ed architetto italiano. Conosciuto per le sue bellissime tavole incise, nei quali ha immortalato l'arte dell’Antichità romana, - monumenti, rappresentazioni scultoree romane, delle rovine, ecc. Il suo stile è caratterizzato da precisione e la fermezza del disegno, mettendo in valore le opere monumentali dell'antica civiltà romana.
Nel 1735, Piranesi ha iniziato la sua carriera artistica studiando architettura con lo zio Matteo Lucchesi, ingegnere presso il "Magistrato delle Acque di Venise", e con il pittore Giovanni Antonio Scalfarotto, poi segue una scuola a Venezia, dove comincia l’arte dell’ incisione con Carlo Zucchi.
Nel 1740 si recò a Roma per completare la sua preparazione d’incisore con Fellice Polanzoni, e in particolare con Giuseppe Vasi, che gli insegna la procedura acquaforte (procedura acido-chimica) sulla piastra metallica. Durante questo periodo Piranesi inizia la realizzazione delle prime serie di tavole con varie immagini di rovine e di monumenti romani antichi di Roma e di altre località d'Italia. Artista di grande talento, Piranesi ha portato l’arte sui più alti livelli della perfezione artistica, il suo stile non essendo mai eguagliato.
Nel 1773-75 sono realizzate le incisioni delle rappresentanze della Colonna di Traiano e di Marco Aurelio. Questo grande artista italiano ha avuto una ricca attività artistica realizzando circa 1.700 lastre di grande formato riunite in diverse serie di volumi.
Pierre-Adrien PÂRIS
Pierre-Adrien PÂRIS (1745-1819), nato e morto nella città di Besançon, nella Francia orientale, è un artista francese che ha avuto una carriera lunga e prestigiosa: architetto, membro dell’Accademia Reale di Architettura, specialista in "architettura" di paesaggio, collezionista di antiquariato, disegnatore dotato di talento, un uomo educato e con passioni vari per l’antichità romana, la letteratura, la storia, la geografia, l’astronomia botanica, ecc. Il primo periodo della sua formazione si svolge tra gli anni 1750 e il 1760 nel campo di applicazione del lavoro del padre, che era geometra, architetto e coordinatore del sito. Nel 1760, Pâris va a suo zio, Jean-Baptiste Lefaivre (capomastro e antrepreneur) a Parigi, poi entra allo studio dell'architetto Louis-François Trouard che lo presenta ai concorsi dell’Accademia. Egli diventa l’allievo dell’Accademia Reale di Architettura nel 1764, dove seguirà i corsi di Jacques-François Blondel. Dal 1765 fino al 1769, Pâris si presenta per il Gran Premio di Architettura che mai vince, e con tutto il suo sforzo, ottiene solo una menzione nel 1768 per un progetto teatrale. Ma lui si è fato noto da « le premier gentilhomme de la Chambre du roi »,, cioè il duca di Aumont a Parigi, che chiede per Pâris una borsa di studio in Italia. Questa protezione e il viaggio sono i fattori chiave della straordinaria carriera di Pâris, che rimarrà per cinque anni a Roma, dal 1769 fino al 1773. Nella capitale dell'antica arte romana, l'artista francese diventa uno dei più grandi conoscitori delle antichità di questa città e dei dintorni. Pâris disegna non solo vari monumenti antichi, ma fa poi dei veri studi di questi. A Roma ha avuto anche l’occasione di insegnare architettura a Francesco Piranesi, il figlio del grande artista Giovanni Battista Piranesi e di viaggiare nel sud dell’Italia dove visita il Cadoue, Paestum, Pompei ed Ercolano. Con stretti rapporti di amicizia con l'abate di Saint-Non, egli collabora al lavoro di quest’ultimo, Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile, che sarà stampato a Parigi, in più volumi.
Tornato in Francia (1774), aureolato da una fama e prestigio rari per un giovane artista, Pierre-Adrien Pâris ritrova la protezione del duca di Aumont e decora gli appartamenti del hotel dello stesso (ora il prestigioso Hotel Crillon di Place Concorde, Parigi). Nel 1778 Pâris è nominato al posto di M.-A. Challe, disegnatore della stanza e del gabinetto del re; queste caratteristiche importanti gli conferiscono la responsabilità di fare la gran parte dei decori di festa, delle pompe funebri, per i teatri, ecc.
Verso la fine della sua vita, Pâris viaggia di nuovo in Italia, nel 1806, dove rivedrà le famose località antiche del Sud della penisola.
Durante l’amministrazione dell'Accademia di Francia a Roma, nominato per ordine di Napoleone, egli sorveglierà il trasferimento delle opere antiche della collezione Borghese (Roma) a Parigi. In effetti, tra il 1808 e il 1809 egli sarà responsabile per organizzare il trasporto dell’antiquariato dalla Villa Borghese per Napoleone che aveva comprato questa famosa collezione, una dei più importanti d’Italia, e che ha voluto portare a Parigi.
Tra i numerosi vestigi studiati e disegnati da Pâris a Roma c’è anche la Colonna di Traiano tanto delle immagini generali, quanto dei rilievi. Lo stile di Pierre-Adrien Pâris è caratterizzato dalla resa accurata del dettaglio, la precisione della linea, che è molto vicina alla linea dello stile del periodo dell’arte durante il regno di Traiano (98-117 dC). I suoi disegni rappresentano veri restituzioni dell’antico iniziale.
Eugene Emmanuel VIOLLET-LE-DUC
Eugene Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814-1879), nato il 27 gennaio 1814 a Parigi e morto il 17 settembre 1879 a Losanna, è un famoso architetto francese noto specialmente al pubblico per i suoi restauri fatti a numerosi edifici medievali noti, e che proveniva da una famiglia "nobile" borghese (il padre era un alto funzionario, dopo il 1830, conservatore capo delle residenze reali di Louis-Philippe). Un buon autodidatta si è educato durante i suoi viaggi in Francia e in Italia fra il 1835 e il 1839. Allo stesso tempo, ha imparato la base del suo mestiere dall’ architetto Achille Leclere.
Nel 1840 Prosper Mérimée, "Ispettore generale dei monumenti storici", gli affida il restauro della basilica di Sainte-Madeleine de Vezelay, ha solo 26 anni e sta iniziando una grande carriera. Sempre nel 1840, Viollet-le-Duc collabora con Jean-Baptiste Lassus per il restauro della cattedrale di Saint Chapelle di Parigi. Nel 1844 Lassus et Viollet-le-Duc sono nominale quali architetti della cattedrale Notre-Dame de Paris. Poi ottiene il permesso, nel 1847, di ripristinare le cattedrali di Saint-Denis (a nord di Parigi) e Saint-Sernin a Tolosa. I monumenti che sono stati restaurati da Viollet-le-Duc sono stati numerosi, come per esempio: i muri di difesa della città medievale di Carcassonne, le cattedrali di Amiens, Chartres, Clermont-Ferrand, la ricostruzione quasi completa del castello Pierrefonds, ecc., ecc. Inoltre, tutte queste opere importanti (questi siti di grandi dimensioni) non l’hanno impedito di fare anche altri lavori, tanto importanti e complessi: la creazione di più edifici religiosi, case private a Parigi, la progettazione di vetrate, monumenti funerali, ecc.
Tutte le ricerche e gli studi di architettura ha raccolto e pubblicato in un grande opera dal titolo completo, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du du XIe au XVIe siecle, composta da 10 volumi (pubblicati tra il 1854 e il 1868), cui si aggiungerà i 6 volumi, Dictionnaire raisonné du mobilier français (1858-1875).
Oltre alle sue preoccupazioni di base, teorico e restauratore di monumenti architettonici medievali, Viollet-le-Duc è anche un disegnatore speciale dotato di un talento speciale, autore di numerosi studi, disegni e acquerelli realizzati durante i suoi viaggi. Andò anche a Roma, dove ha studiato antichi monumenti romani, e tra questi monumenti è stata anche la Colonna Traiana, riproducendo dei dettagli da questo monumento famoso e di grande importanza artistica. Notiamo in queste opere d'arte, la grande qualità dei suoi disegni nonché la precisione della sua linea artistica di architetto; Viollet-le-Duc è un erudita complesso con eccezionali capacità fisiche e mentali.
- Vedi Salvatore Settis, « La Colonne Trajane : l’empereur et son public », în RA, 1991, 1, p. 186-188 e la nota 2.
- Alain Malissard, « La Colonne Trajane, images et récit », în Caesarodunum, supplemento n. 19, 1975 ; Aurel Decei, « Adevăratul chip al regelui Decebal », în Sargeţia, XIV, 1979, p. 71-72 ; Raymond Chevallier, Alain Malissard, « Dix-neuf siècles de découverte de la Colonne Trajane », în Les dossiers de l’archéologie, nr. 17, luglio-agosto 1976, p. 91 (vecchi riproduzioni) ; Filippo Coarelli, La Colonna Traiana, 1999, Editore Colombo, Roma, p. VII-VIII ; Radu Vulpe, Columna lui Traian (Trajan’s Column), Bucureşti, CIMEC, 2002, p. 14-15, 108-109.
- Vedi anche Alain Malissard, « Où peut-on voir la Colonne Trajane », in Les dossiers de l’archéologie, nr. 17, luglio-agosto 1976, p. 126.